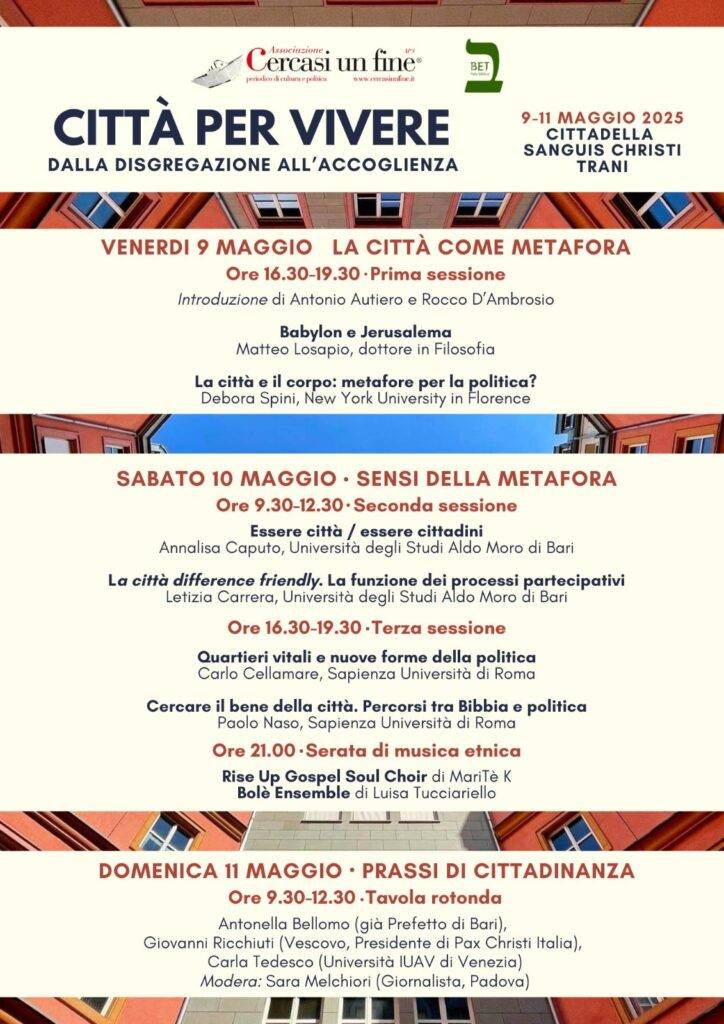Mi si capirà e perdonerà se, da povero cristo italiano ed europeo, mi sento molto a disagio nella evidente tendenza delle due maggiori potenze internazionali a dominare il mondo in nome e per conto del «primato della forza».
Certo tale primato è stato una ricorrente tentazione storica (si pensi alle ambizioni di Napoleone, di Bismarck e più tardi di Hitler); ma questa volta la tentazione sembra più pesante, quasi volgare nella sua forzuta comunicazione di massa e nella esclusione di chi «non ha le carte» e di coloro che fin qui hanno «vissuto da parassiti». Così chi è fuori dalla «forza» si trova di fronte ad un bivio: o si accuccia nell’anonimato, pensando che alla fine «passerà la nottata»; oppure si schiera con uno dei due attuali «forzuti» (e magari da buon Arlecchino con tutti e due).
Ci porteranno gli anni chissà quanti altri affanni, ma intanto c’è qualcosa che noi, poveri cristi italiani ed europei, possiamo e dobbiamo affrontare: fare un serio esame di coscienza; capire se c’è una speranza per il futuro; «sentirci» partecipi e responsabili di tale speranza.
Anzitutto dobbiamo fare un esame di coscienza. Noi italiani ed europei fedeli ai nostri valori di libertà, di policentrismo dei poteri, di rispetto delle regole democratiche, siamo stati storicamente vittoriosi (nella guerra ’40-’45 e con la caduta del Muro di Berlino), ma non ci siamo resi conto che non potevamo chiuderci in un presuntuoso etnocentrismo occidentale, divenuto peraltro sempre più fragile di fronte al moltiplicarsi di diverse culture e nuovi poteri. E alla fine siamo diventati minoritari, spesso colpevolizzati da qualche ridicola piega di «cancel culture»; e talvolta tentati da qualche fuga in avanti, verso lidi troppo indistinti (nella politica di genere o nella cosiddetta democrazia diretta), per non creare una crescente fragilità di fronte all’attuale primato della forza, c’è stata nei fatti una decisiva carenza di orgoglio collettivo in tutte le società europee, quasi dimenticando che una monaca, Ildegarda di Bingen, contrastò Federico Barbarossa (un grande forzuto medievale) ricordandogli di possedere una «spada con cui potrei ucciderti». Altri tempi, ed altre donne…
E viene spontaneo far notare come la maggiore carenza di orgoglio sia oggi riscontrabile proprio nella cultura cattolica, che per anni è stata scompaginata dal grande processo di secolarizzazione e che ha trovato senso attestandosi nelle retrovie dello sviluppo attuale, coltivando il primato dei deboli e dei fragili (ed una relativa funzione di ospedale da campo) e schierando su di esso il grosso dell’apparato ecclesiale. Il cattolicesimo è così diventato implicitamente una subcultura, magari subalterna a tante altre. Ed ha in conseguenza perso la sua capacità di accompagnare la duplice marcia degli uomini «verso l’avanti e verso l’alto», verso il progresso sociale e verso la trascendenza. Perdendo di conseguenza l’universalismo della propria testimonianza evangelica.
La crisi è sottile, ma drammatica. Ed è giunto il momento di individuare una linea di speranza, riandando all’orgoglio della badessa di Bingen, fulcro di una possibile strategia europea nel contrasto ai forzuti d’oriente ed occidente, puntare sulla promozione umana, di tutti gli uomini e di tutto l’uomo, vuol dire scatenarne la forza autopropulsiva e la libertà creatrice dello spirito unico e irripetibile che anima ogni persona. Serve per questo un lavoro dello spirito e un’alleanza tra chi fa questo lavoro, credenti e non, come proposto da Massimo Cacciari in un incontro promosso dal Cardinale Reina la settimana scorsa, nella cattedrale di San Giovanni in Laterano e dedicato alla responsabilità di tenere unite e non divaricate le due attuali anime della cultura cattolica, secondo l’intuizione del ‘76 di Mons. Bartoletti, allora Segretario Generale della CEI, di unire «Evangelizzazione e Promozione Umana» nel titolo del primo convegno nazionale della, con una forte insistenza sull’et-et delle due prospettive. Per anni tale unità si era andata perdendo, l’enfasi sulla prima ha di fatto emarginato la promozione umana, ma non ha evitato il progressivo crescere di indifferenza e di disimpegno nella partecipazione alla vita ecclesiale. È forse arrivato il momento di rilanciare una logica unitaria della fede e dell’agire sociale, muovendosi «in avanti e in alto».
L’incontro a San Giovanni ha fatto sospettare ad una rivista americana conservatrice che abbia vinto una ipotesi troppo teilhardiana. Ma Teilhard de Chardin è morto da settanta anni e non fa più paura «ai superiori»; e forse il popolo cristiano è nel tempo cresciuto e sa che guardare avanti e in alto è l’unico modo per unire tutti i fedeli: quelli che da sempre lavorano nell’apparato della Chiesa ed ogni eventuale i figliol prodigo dell’ultimo momento. Perché, in fondo, «Uno è il Padre ed Unica è la promessa».
hcorriere.it/opinioni/25_aprile_04/il-disagio-e-la-nostra speranza-498e6438-04bc-4d3d-96bd-7541d9e71xlk.shtml?refresh_ce