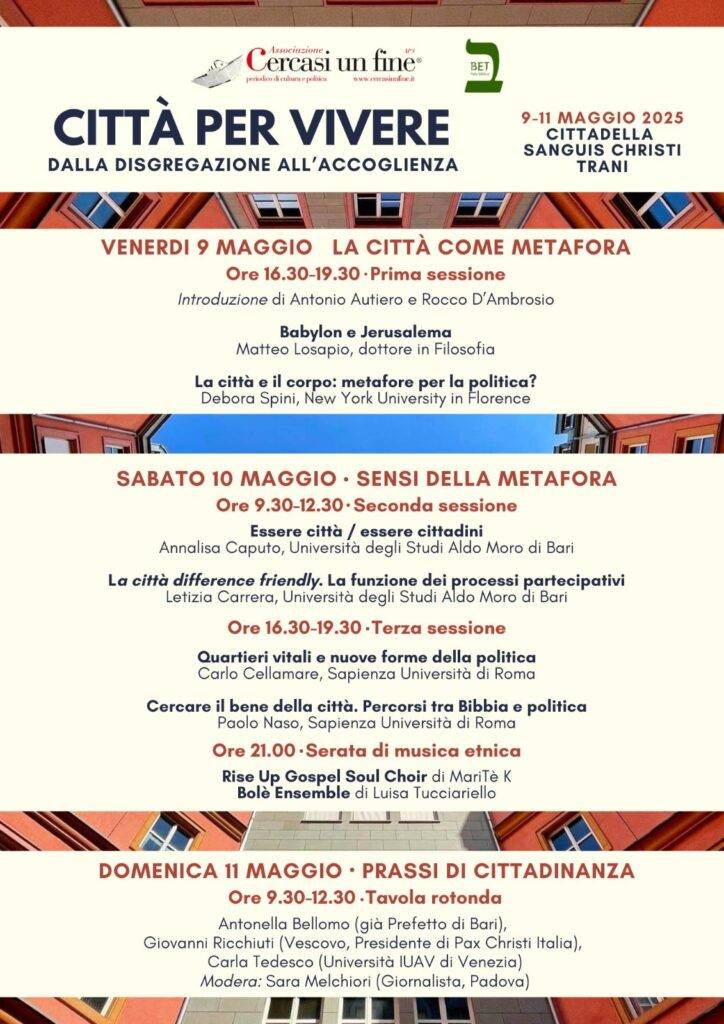Se considerassimo il mercato del lavoro come l’oltretomba dantesco, potremmo immaginare regni diversi. C’è chi vive in un paradiso di stipendi alti e molte tutele, c’è chi sta nel purgatorio di contratti a tempo determinato e stipendi che hanno perso valore. Ma c’è anche chi sta all’inferno, alle prese con sfruttamento, paghe da fame, violazione anche delle più elementari norme di sicurezza.
Questo non è lavoro, libro di Giampiero Falasca, parla proprio di questo gruppo, di coloro che potremmo definire i dannati. Di questo libro e della situazione del lavoro, in rapporto ai giovani, si è parlato lunedì 31 marzo, presso i Laboratori aperti di Modena, in una serata organizzata dal Centro culturale Francesco Luigi Ferrari e patrocinata dal Comune di Modena. Tra i partecipanti, oltre all’autore e all’assessore modenese per le politiche giovanili Andrea Bortolamasi, anche diversi giovani che hanno raccontato la loro esperienza e chiesto a Falasca ulteriori spiegazioni sulla situazione che stanno vivendo e che vedono intorno a loro.
“Dannato lavoro”
«In Italia – ha esordito Giampiero Falasca – ci sono 3 milioni di persone che vivono fuori dalle regole. Il loro non può essere definito un lavoro precario ma piuttosto un lavoro dannato, tanto è vero che il titolo che avrei voluto dare a questo libro era “Dannato lavoro”. Parliamo di camerieri, rider, lavoratori della gig economy, ma anche giornalisti, praticanti avvocati o assegnisti di ricerca. La politica ha delle enormi responsabilità: negli ultimi 20 anni abbiamo assistito a quello che io amo definire populismo giuslavoristico, si è fatto credere agli elettori che potevano essere trovate soluzioni semplici a problemi molto complessi. Abbiamo assistito a ministri che esultavano da un balcone per l’abolizione della povertà o che pensavano di ridare dignità al lavoro attraverso un decreto. E queste semplificazioni hanno colpito tutti gli schieramenti politici. Poi c’è una responsabilità anche delle imprese e delle parti sociali. Ma il vero colpevole, a mio parere, è il consumatore: andiamo tutti a cercare prodotti a prezzi sempre più bassi, senza considerare cosa c’è dietro quel prezzo, senza ricordare che il lavoro ha un costo».
Ma il lavoro dannato non colpisce tutti allo stesso modo. Ad essere più discriminate sono le fasce lavorative più deboli: le donne e i giovani. Ancora adesso è possibile imbattersi in annunci di lavoro che si configurano come dei veri e propri reati: avvocatesse a cui sono chiesti tacchi a spillo e bella presenza, assenza di impegni familiari e rifiuto all’idea di avere figli, contratti part-time per 50 ore settimanali, salari che non permettono di superare la soglia di sopravvivenza. Falasca, nella sua ricerca, ha trovato camerieri addestrati a travestirsi da clienti in caso di controlli, o annunci che richiedevano capacità di guidare un motorino reggendo un vassoio.
Secondo un’indagine citata nel libro, a oltre la metà degli under 35 il mercato del lavoro offre solo contratti irregolari, prestazioni di fatto in nero, difficoltà a trovare un’occupazione e condizioni lavorative disagiate. A cinque anni dal completamento degli studi, i giovani intervistati hanno lavorato in media tre anni e mezzo. Solo il 37,2% del campione ha un lavoro stabile, mentre il 26% ha rapporti a termine, il 23,7% è disoccupato e il 13,1% è studente-lavoratore. Numeri che devono farci riflettere e che spiegano anche la vera e propria emorragia di giovani che stanno lasciando il nostro paese: 700.000 i giovani laureati che hanno lasciato l’Italia dal 2011 a oggi, con un boom di emigrati del +36% nel 2024.
Ma, al di là delle cifre, è importante parlare con i giovani, capire quali sono le loro aspirazioni e qual è la realtà che ogni giorno toccano con mano. L’impressione è che ci sia una grande difficoltà di comunicazione fra ciò che offre il mondo del lavoro e ciò che vorrebbero i giovani. C’è un tema di incapacità della scuola ad allinearsi con la realtà delle aziende, ma c’è anche un grande tema culturale. Richiamare che «i giovani di oggi» non hanno propensione al sacrificio e non «non sono più quelli di una volta», è estremamente riduttivo: molti oggi non cercano solo una paga, ma vogliono un lavoro che dia loro la possibilità di coltivare altre passioni o che comunque si inserisca in un orizzonte di senso.
Problema retribuzioni
A intervenire sono stati due ingegneri, un assegnista di ricerca, un medico specializzando in psichiatria, un’educatrice e un’operatrice culturale. A colpire i ragazzi è, innanzitutto, la grande distanza fra ciò che viene insegnato a scuola e nelle università e ciò che è effettivamente richiesto sul luogo di lavoro, anche a fronte di specializzazioni.
È uno dei problemi più importanti in una regione come l’Emilia-Romagna che finisce poi per manifestarsi nella grande questione del mismatch tra domanda e offerta di lavoro: le imprese denunciano la mancanza di lavoratori, ma allo stesso tempo ci sono molti giovani che non riescono a trovare un lavoro soddisfacente e in linea con gli studi fatti. E non è solo questione di adattamento, visto che spesso si arriva anche a calpestare le più basilari norme.
«Noi specializzandi – ha spiegato la dottoressa Aurora Marchi – siamo un ibrido fra lo studente e il lavoratore. Il problema è che spesso ci vengono date responsabilità e mansioni che vanno ben oltre le nostre competenze e capacità. Ho colleghi che hanno dovuto prendere decisioni importanti, in un ambito delicato come quello della psichiatria, senza avere la necessaria preparazione alle spalle. E poi c’è un problema di sfruttamento. Alcuni sono costretti a fare una quantità così grande di ore che, se considerassimo la paga oraria, saremmo ben al di sotto di quanto prescritto dalle sentenze della Corte costituzionale. Si dice spesso che c’è un problema di carenza di personale sanitario e ancora oggi c’è chi immagina che togliere il numero chiuso da Medicina possa essere la soluzione, quando il problema è un altro: i medici ci sono ma ci sono alcune specializzazioni che non vuole più fare nessuno, perché sappiamo benissimo che, in alcuni ambiti, le condizioni sono terribili e nessuno vuole vivere con certi orari e certe situazioni».
Alberto Avallone, ingegnere informatico e assegnista di ricerca presso Unimore, ha sottolineato invece il problema delle retribuzioni. «Un dottorando prende 1100 euro al mese, un assegnista ancora meno. Quindi per campare o hai una buona famiglia alle spalle, o ti fai aiutare dal tuo professore ad avere qualche lavoro in più o semplicemente fai lezioni private in nero. Abbiamo dei ricercatori di assoluta eccellenza, che discutono alla pari con le migliori università al mondo e che guadagnano quanto un camionista». Soprattutto per chi lavora nell’ambito dell’istruzione e della cultura le retribuzioni sono vergognosamente basse.
Scelte politiche
«È triste da dire – ha risposto Giampiero Falasca – ma dobbiamo avere il coraggio di ammettere che molti di questi problemi sono frutto di deliberate scelte politiche. Se anziché investire su sanità e cultura si è investito su bonus facciate e bonus 110%, questa non è una casualità. Le risorse pubbliche sono scarse per definizione, a fronte alle molte necessità, ma poi ci sono le scelte di chi governa».
Come ridare una nuova dignità al lavoro, sia a quello di chi vive il purgatorio di precarietà e basse retribuzioni sia quello di chi è vittima di vessazioni e negazioni dei più basilari diritti? Sicuramente è importante una nuova consapevolezza da parte dei consumatori.
«Così come siamo attenti a vedere la composizione dei prodotti che mangiamo – ha concluso Falasca – dobbiamo diventare bravi anche a leggere le situazioni di inaccettabile sfruttamento. Il lavoro ha un costo. Ogni volta che acquistiamo un prodotto a prezzo stracciato, stiamo in realtà speculando sul lavoro di qualcuno».
Ma è sicuramente necessaria anche una nuova stagione di consapevolezza politica. Così come, all’epoca della prima industrializzazione, i lavori si sono organizzati per far valere i loro diritti, contro imprenditori senza scrupoli e legislazioni ostili, così è necessario ritrovare una nuova consapevolezza sindacale e politica in cui i lavoratori sappiano operare uniti per ottenere diritti che, in linea teorica, sarebbero già stati concessi.
Abbiamo cioè bisogno di una politica che torni a fare il suo mestiere, vale a dire operare per un cambiamento della realtà. E di giovani che imparino a organizzarsi e a prendere in mano il timone.
Da Settimana News del 7 aprile 2025 (reportage da Modena di Federico Covili)
https://www.settimananews.it/societa/modena-giovani-e-sfida-del-lavoro/