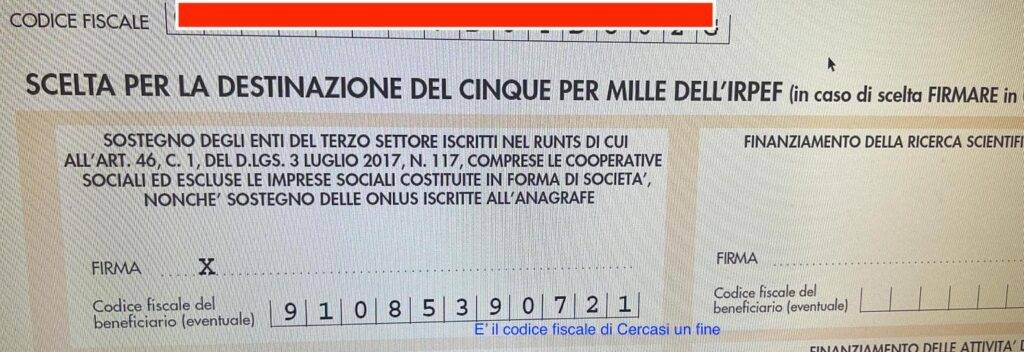Per chi studia architettura o ascolta Battiato, il nome di Le Corbusier, risuona come una leggenda vivente o un mostro razionalista. Il perno della sua opera architettonica, come ben sappiamo, è l’unitè d’habitation, un modo di vivere armonico più che standardizzato. È su questo punto che mota dell’architettura e del pensiero sull’abitare hanno confuso l’intuizione dell’Architetto svizzero dell’unità abitativa con la standardizzazione architettonica.
Innanzitutto, per Le Corbusier, la casa non è semplicemente un tetto con muri che lo sorreggono ma è una membrana osmotica che permette l’interazione dell’essere umano con l’ambiente che lo circonda. La casa, insomma, funziona come una pelle, come un abito che aiuta i processi biologici dell’essere umano ad interagire meglio con l’ambiente circostante. E vogliamo volutamente giocare sul binomio abito/abitare per interpretare l’unitè d’abitation. Scrive Le Corbusier:
La casa è un involucro che risponde a certe condizioni e stabilisce giusti rapporti tra l’ambiente cosmico e i fenomeni biologici umani. In essa dovrà vivere un uomo (o una famiglia), dormendo, camminando, sentendo, vedendo, pensando. Che sia fermo o in movimento, gli occorreranno una superficie adeguata e un’altezza delle stanze commisurata ai suoi gesti. Alcuni mobili o arredi sono come un’estensione delle sue membra e delle sue funzioni. Certe necessità biologiche imposte da abitudini millenarie e che a poco a poco sono entrate a far parte della sua stessa natura, esigono la presenza di elementi e di condizioni precise, perché egli non deperisca: sole, spazio, verde. Per i suoi polmoni un’aria adatta; per le sue orecchie, un grado sufficiente di silenzio; per i suoi occhi, luce favorevole.[1]
Ancora di più di un involucro, la casa per Le Corbusier è un prolungamento abitativo dell’essere umano, in una visione integrale e sensoriale dell’essere umano. È vero che Le Corbusier iscrive la sua architettura all’interno di una precisa visione antropologica legata alle forme e alle proporzioni, ma ciò che ci sembra più importante è questo nesso fra l’abito e l’abitare che conferisce ulteriore significato all’unità abitativa da lui proposta. Infatti, non si tratta di ritornare alla visione antropologica di Le Corbusier ma di poter reinterpretare la relazione fra essere umano e ambiente in maniera contemporanea. Se, infatti, fino a questo momento abbiamo interpretato l’unità abitativa come uno standard a cui adeguare ogni architettura e ogni tipologia edilizia, ci occorre riguadagnare il senso dell’abitare come un abito su misura e la cui misura è nell’umano inadeguabile ad ogni standard. Nel passeggiare dentro l’unitè d’habiation a Marsiglia, infatti, si ha la percezione che tutto sia regolato da una armonia che favorisce l’interazione con lo spazio circostante. Si tratta di camminare non in un grande condominio ma in uno spazio fatto di aria, di sole, di illuminazione, di rue, di vie e non di corridoi. Un modo di abitare che, come ogni abito, ogni tanto esige anche di uscire fuori, esige anche un modo di vestire/abitare differente, ma che non fa sentire mai fuori posto o a disagio. L’unitè d’habitation è per una quotidianità, un modo di abitare il quotidiano, comodo e funzionale, pratico e civile, dignitoso e non alienante. Un abitare di qualità attraverso cui Gio Ponti criticava, invece, l’approccio quantitativo delle politiche italiane sulla casa già nel 1980.
Da noi esiste un piano finanziario, il Fanfani-case, che provoca e promuove, quantitativamente, le costruzioni. Ma come? Il piano non fa distinzione fra casa e casa, non esige affatto le case migliori, non conosce l’architettura, è indifferente, è estraneo a questa ambizione di cultura, e – diciamolo di civiltà. Come avvenimento architettonico ha esso forse la risonanza mondiale che la Francia raggiunge con l’evento di Marsiglia? Il nostro piano ha determinato esclusivamente un meccanismo finanziario, una deviazione di capitali verso le case. Ma non ci garantisce affatto, anzi, che l’Italia. la santa Italia, in virtù del successo del Piano non risulti proprio coperta un giorno di brutte case, di inintelligenti architetture.[2]
Qui si colloca la differenza fra l’unità abitativa di Le Corbusier e lo standard architettonico. Su una differente concezione dell’umano, da una parte qualitativo e dall’altra quantitativo. Quelle che chiamiamo comunemente case popolari riecheggiano uno standard della casa per cui tutto è identico a se stesso, tutto è serializzato, tutto è funzionale ad una visione finanziaria della casa, per cui chi ha di più può permettersi una casa su misura e i meno abbienti delle piccole scatole serializzate da chiamare “casa”. Un abitare su misura che è segno di una misura economica, di una visione antropologica che non sta a guardare le forme dell’umano, la sezione aurea, ma l’oro che ciascun individuo possiede. Con questo intervento, dunque, non vogliamo né santificare né condannare Le Corbusier, ma vogliamo mettere in risalto due elementi.
Il primo è come l’unità abitativa non sia confondibile con uno standard abitativo, ma sia un modo di abitare unitario che permetta ad ogni persona di vivere in unione con se stesso e con le altre persone. Da questa prima considerazione, dunque, l’unita abitativa riguarda una unità personale dell’abitare, una possibilità di abitare facendo sintesi in se e comunità con le altre persone. Elementi che l’architettura, da sola, non può risolvere senza l’apporto di tutte le altre discipline e, soprattutto, non può risolvere senza l’aiuto degli abitanti stessi.
Il secondo elemento che vogliamo mettere in risalto è come l’unitè d’habitation sia stata concepita non per i ricchi o i benestanti ma per i cittadini. Un abitare bello e spazioso per le persone comuni, dall’impiegato all’operaio. Certe volte pensiamo che i poveri, per il solo fatto di essere poveri, non possano permettersi la bellezza, ma siano in un certo senso condannati e meritevoli di vivere in ambienti degradati e serializzati. In questi ultimi giorni il nostro pensiero non può che andare alle Vele di Scampia in cui sono morte delle persone e altre sono rimaste ferite, fra cui bambini, non solo perché vivono in un ambiente identico e alienante ma per scarsa manutenzione dei cornicioni. L’unità abitativa è stato un esperimento in cui il vivere anche per le persone meno abbienti è segnato da una dignità e da una qualità alta, anche come mezzo di riscatto civile e sociale a cui l’architettura può contribuire.
Spesso, quando visitiamo un monastero, rimaniamo meravigliati del silenzio, della pace, della tranquillità, della bellezza che circonda quel luogo. Ebbene, è proprio questa sacra bellezza il punto di origine della lezione di Le Corbusier che lo ha portato all’unitè d’habitation. La lezione, dunque, che possiamo ancora apprendere dall’unitè d’habitation di Marsiglia e portare avanti anche superandola, è come l’abitare sia un abito che ciascuno di noi intesse nella relazione fra sé e il mondo, un abito che quanto più è bello tanto più è capace di rendere belli noi e coloro che incontriamo/ospitiamo, fino ad aggiungere un po’ di bellezza e dignità al mondo. Fino a divinizzarci.
[1] Le Corbusier, Maniera di pensare l’urbanistica, Laterza, Bari 2020, p. 57-58.
[2] G. Ponti, La Cité Radieuse di Le Corbusier, Domus (https://www.domusweb.it/it/dall-archivio/2011/02/28/la-cite-radieuse-di-le-corbusier.html).